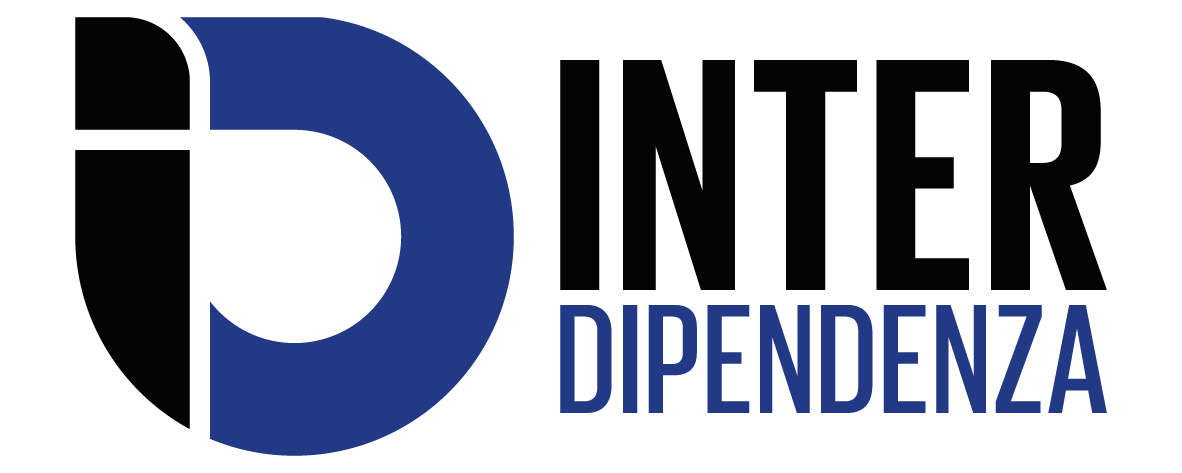Mazzola: “Vi racconto tutta la mia storia in nerazzurro…”
Alessandro Mazzola ha segnato la storia dell’Inter a suon di gol e grandi prestazioni, diventando una delle bandiere del club. Domani compirà 73 anni, e oggi si racconta in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Mazzola ripercorre tutto il suo passato calcistico, dagli inizi della carriera fino a quando è arrivato ad essere uno tra i più grandi calciatori italiani di tutti i tempi.
Sandro, è vero che la scoprì Benito Lorenzi, detto “Veleno” per il suo caratteraccio?
“Sì e no. Lui era un tipo un po’ strano. Era immensamente grato a mio padre perché papà vide che lui, in Nazionale, non giocava mai, chiuso dai giocatori del Torino. Allora andò da Pozzo e gli disse di fargli fare una partita. Da quel momento per Lorenzi Valentino Mazzola era un semidio. Portava Ferruccio e me allo stadio come mascotte dell’Inter. E se la squadra vinceva o pareggiava lui sosteneva con il presidente che dovevano dare il premio partita anche a noi, che portavamo fortuna”.
Fu lui a farle fare il provino in nerazzurro?
“No. Lui diceva sempre che ci avrebbe accompagnato lui. Ma non lo fece. Finché il mio patrigno non decise che dovevamo provarci e andammo. Ci vide Giuanin Ferrari e ci prese. Così io a quattordici anni firmai il mio primo cartellino. C’era scritto “tesserato all’Inter a vita”. E così è stato. Nonostante una telefonata di Boniperti, amico e collega di papà, che mi voleva alla Juventus. Mentre parlavamo mi passò l’avvocato Agnelli. Io me la stavo facendo sotto ma tenni botta. Ringraziai ma dissi che non potevo tradire l’Inter. Così è andata”.
Come era Helenio Herrera?
“Ci diceva sempre che lui doveva allenare prima la nostra testa e poi le gambe. Ma ci faceva faticare da pazzi. Compreso il lunedì. E poi i ritiri. Lui, non il medico, faceva la dieta. Il giorno della partita ci faceva mangiare un filetto al sangue alle dieci di mattina. Io non ci riuscivo. Ma per reggermi in piedi, in campo, mi ero messo d’accordo con un mio vecchio amico di Cassano che aveva aperto una panetteria a Milano. Mi faceva tre panini che io mangiavo di nascosto al Mago”.
Torniamo al suo esordio. Fu in una strana partita. Nel 1961 l’Inter mandò in campo, per protesta, la squadra Primavera contro la Juve. Fu un fatto clamoroso.
“Io lo ricordo così: avevo tre interrogazioni a scuola. A quei tempi mi dibattevo regolarmente tra il cinque e il sei. E quel sabato si erano concentrate le tre interrogazioni decisive per la promozione. Io però non ci pensavo, non era la mia priorità. Tornai a casa entusiasta e dissi a mia mamma che avrei giocato in serie A. Lei mi rispose che non ci pensava neanche a mandarmi, che la scuola era più importante. Ma all’Inter anche non sentivano storie, pensavano che la presenza in campo del figlio di Mazzola avrebbe attenuato l’offesa recata alla Juve. Insomma ero strattonato da due parti. Fu Allodi a trovare la soluzione. Parlò col Preside e mi fece interrogare nelle prime tre ore. Poi mi mandò a prendere con il taxi. Si immagini l’entusiasmo dei miei compagni di scuola. Mi mangiai dei panini durante il viaggio”.
Come fu l’impatto con il grande calcio?
“Quando uscii dallo spogliatoio mi venne incontro Boniperti: ‘Io ho giocato con tuo papà, era il più forte di tutti: State tranquilli, sappiamo che siete dei ragazzi. Non ci impegneremo’. Tra i miei compagni di squadra, nella Primavera, c’era Morosi, un ragazzo grosso e buono che in campo mi difendeva quando i difensori avversari mi menavano troppo. Si avvicinava a questi e gli sibilava ‘Se non la smetti di picchiare Sandro ti spacco in due’. In genere funzionava. Quel giorno marcava Sivori. Dopo dieci minuti Sivori non aveva ancora segnato e lui mi gridò, tutto felice ‘Sto bloccando Sivori, al paese mi faranno sindaco!’. Poi Omar decise che era tempo di cominciare a giocare e ne fece sei. Il povero Morosi tornò a piedi a Milano, per la vergogna”.
Poi arrivarono il primo ingaggio e il vero esordio.
“Mi chiamarono per andare in sede. Allora non c’erano i procuratori. Poi io ero talmente emozionato, in mezzo alle foto di tutti i campioni della storia interista, che se mi avessero offerto una gallina vecchia avrei accettato. Invece mi proposero 40.000 lire al mese più i rimborsi spese. Mia madre, quando tornai, non ci credeva. Mi disse che mi ero sbagliato, era troppo. Il secondo contratto fu addirittura di 120.000 lire e mia madre diventò matta. Disse che neanche papà prendeva tanti soldi. Ricordo che quella sera, per festeggiare, volle che andassimo all’osteria a prendere una bottiglia di vino. Di solito dovevamo farcela bastare per una settimana. Quella sera volò via, doveva essere celebrato come un momento eccezionale”.
Quale è stato il momento più bello che ha vissuto nell’Inter?
“La prima finale di Coppa dei Campioni con il Real Madrid. Deve sapere che noi non avevamo la tv. Si andava all’osteria e, se consumavi una spuma, potevi vedere la partita. Tutte le finali della coppa prima le giocava o vinceva il Real. Io ero innamorato di Alfredo Di Stefano che tutti dicevano giocasse proprio come papà. Lo adoravo: elegante, tecnico, sempre con la testa alta. Al Prater me lo vidi davanti all’improvviso, mentre aspettavamo di scendere in campo. E restai imbambolato. Per me era un divo della tv. Finché Suarez mi batté sulla spalla e mi disse ‘Noi scenderemmo in campo, tu resti qui a guardare Alfredo?’. Feci anche un gol, quella sera. In verità non voluto, quasi per caso, ma non fa nulla. Festeggiai in modo plateale, non la finivo più. Sempre Suarez mi disse ‘Guarda che se non smetti questi ce ne fanno quattro’”.
E il momento più brutto?
“In una settimana, nel 1967, perdemmo Coppa dei Campioni e scudetto. Prima con Il Celtic e poi con il Mantova, in quella maledetta partita. I loro difensori dicevano che mi avrebbero fatto segnare. Ma io non ci riuscii. Poi ci fu quel maledetto errore di Sarti. Ma io lo conosco bene e so che fu un errore di un portiere che cercava di rendere facili le cose difficili. Non credetti certo alle cattiverie che misero in giro sul suo conto quando l’anno dopo passò alla Juventus. La verità è che perdemmo quelle partite perché era finito un ciclo e la società aveva già fatto sapere che intendeva vendere alcuni giocatori. Game over, pensammo inconsciamente. Ma quando tornai in auto da Mantova, con il mio patrigno, piansi lo stesso per tutto il viaggio”.
La sua formazione ideale di tutti i tempi?
“Ghezzi, Burgnich, Jack Charlton, Picchi, Facchetti; Beckenbauer, Rivera, Pelè; Van Basten, Cruyff, Messi. Allenatore ovviamente Helenio Herrera”.
Parliamo di due campioni della sua Inter che non ci sono più. Cominciamo da Facchetti.
“Giacinto era un grande, ha inventato un modo nuovo di fare il terzino. Fluidificava bene, segnava tanto. Nel gruppo se ne stava molto per conto suo. Per lui Herrera era una specie di Dio. Non ammetteva che sbagliasse. Quando noi protestavamo perché il Mago esagerava, era troppo cerbero, lui si metteva in disparte”.
E Picchi?
“Giocatore geniale, grande capitano. Lui prevedeva tutto. Una volta, in una partita decisiva per lo scudetto, dovevo battere un calcio di rigore, anch’esso decisivo. Ma ero inquieto. Perché il portiere, William Negri, era con me in nazionale e sapeva come tiravo e poi perché il campo era pesante per la pioggia e il fango. Mi accorsi con sorpresa che Picchi stava venendo al limite dell’area, lui che non lasciava mai la sua. Mi vide titubante e mi disse ‘Dammi la scarpa’, poi me la pulì con la sua maglietta. Allora mi guardò negli occhi e mi rassicurò ‘Adesso puoi fare gol’. Segnai con quella scarpa, pulita da un campione di calcio e di vita”.