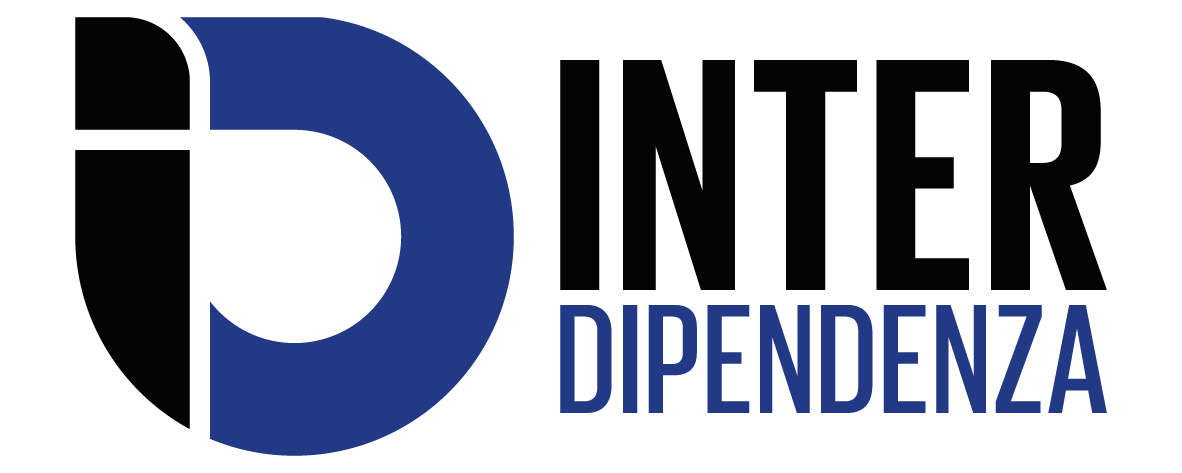Angelo Domenghini: pochi sorrisi ma tanti polmoni per l’Inter di HH
Un ritratto un po’ diverso di uno dei campioni della grande Inter di Helenio Herrera. Una caratteraccio ma una generosità senza limiti
In questi giorni l’Atalanta fa un gran parlare di sé, a ragione, visto quel che sta facendo in campo. L’Europa aspetta i bergamaschi per la prossima stagione, se sarà Champions o Europa League saranno le ultime due giornate a dirlo. Un successo comunque strepitoso per una società da sempre considerata non di primissima fascia, con un unico trofeo nel suo palmares, una Coppa Italia vinta proprio al Meazza nel lontanissimo 1963. Un 3 a 1 rifilato al Torino grazie ad un ragazzo mingherlino che quel giorno mise a segno una tripletta. Quel fascio di nervi all’epoca 22enne era Angelo Domenghini, uno che non avrebbe mai più messo a segno nella sua carriera un “hat trick” ma che il nerazzurro l’avrebbe portato ai vertici del mondo. Non quello dell’Atalanta, l’altro, quello giusto.
Oggi “Domingo” è un tranquillo signore, un nonno felice che divide il suo tempo tra la bergamasca dove vive, e la Sardegna che lo accolse nel 1969 quando a Milano arrivò un certo Bobo Boninsegna dal Cagliari e lui fece il viaggio inverso.
Ma di certo la tranquillità l’ha acquisita con il tempo, non era la caratteristica principale del suo carattere da ragazzino. In una intervista di qualche tempo fa raccontava della sua infanzia, passata in una miseria nera ma dignitosa, in una famiglia con altri due fratelli e sei sorelle.
Prima di far ammattire i difensori avversari, pensò bene di allenarsi con la famiglia ed i vicini. C’è chi lo ricorda arrampicato sugli alberi per fregare la frutta ai contadini della zona, chi sui cornicioni della chiesa per raggiungere le uova nei nidi delle rondini. I suoi lo beccavano spesso a dormire nella stalla o a fumare le pagine dei vecchi giornali.
Non proprio un angioletto insomma, ma uno che aveva un futuro da predestinato. Lo capì quando giocava nel campetto dell’oratorio. Un prete di un paese vicino lo vide e lo portò direttamente in prima Divisione, senza giovanili, senza scuole calcio, senza nessuna trafila. Da li alla rappresentativa giovanile azzurra il passo fu breve. Lì incontrò per la prima volta uno spilungone che sarebbe entrato di prepotenza nella sua vita qualche tempo dopo, Giacinto Facchetti.
Al mattino in fabbrica, poi sul campo da calcio. Lo sbocco naturale per i ragazzi di quelle parti era l’Atalanta. Lo presero per duecento mila lire alla società ed il biglietto del bus per Bergamo a lui. Fino a che il direttore dello stabilimento non si scocciò di quel part time e Domingo scelse di diventare un calciatore a tempo pieno. Un grande conoscitore di calcio, Ferruccio Valcareggi vide quel ragazzo e se lo portò in prima squadra. Fino a quella tripletta, che gli valse il passaggio all’Inter. Era il 1964, Domingo vola in paradiso. “All’Atalanta prendevo un milione all’anno, firmai un contratto in bianco e Angelo Moratti scrisse: quindici. Ero arrivato a Milano con la Seicento, mi sono subito comprato l’Alfa, il Duetto decappottabile”. Insieme a Bruno Mora, sull’altra sponda dei Navigli, fu la prima ala italiana in senso stretto. Puntava l’uomo lo saltava, e poi c’erano Corso e Mazzola a finire il lavoro. Anche lui sapeva inquadrare la porta, specie da lontano, i suoi 50 gol parlano chiaro. Ma all’Inter di quegli anni non c’erano Perisic e Candreva,lui il posto se lo giocava tutte le domeniche con un certo Jair, fatto che costringeva spesso HH a schierarlo un po’ ovunque fuorchè sulla destra. Con risultati comunque entusiasmanti.
Lui giocava dove HH lo metteva, mezzala o centravanti andava bene comunque. Il Mago puntava su questa duttilità e sulla disponibilità del suo Angelo. “Preferisco Domingo là davanti perché lo ritengo più abile a giocare in profondità. Ma l’ho voluto anche perché è un jolly”… Sei in forma. Domenica marcherai Rivera ” gli disse con una pacca sulla spalla. La domenica successiva era di nuovo al centro dell’ attacco.
Angelo parlava poco e rideva ancora meno. Educato e taciturno, sembrava quasi soffrisse della enorme personalità dei suoi compagni più titolati. Sorrideva poco anche quando poteva sfogare la sua grande passione per la caccia, forse perché nei boschi era sempre insieme ad un altro mostro di ilarità come Tarcisio Burgnich.
Ma il carattere non si cambia. Una notte nell’aprile del 1965, ad un orario in cui un giocatore dovrebbe essere a letto già da tempo, la sua Giulietta TI ebbe uno scontro micidiale con un’altra auto. Angelo sembrava in condizioni gravi ma per fortuna il lago di sangue da cui venne raccolto usciva tutto dal suo braccio, dove si erano conficcati una lamiera ed un vetro. La degenza fu lunga, Domingo aveva paura. Non solo di perdere il posto in squadra ma anche perché si seppe che l’Alfa Romeo non era la sua ma di un amico garagista che gliela aveva prestata essendo la sua in riparazione. Temeva una punizione della società. Beppino Prisco capì l’antifona e applicò il suo codice disciplinare personale : “Punirlo? S’è già punito da solo”.
In campo era un moto perpetuo, su e giù come uno stantuffo, sulla fascia o più accentrato. Una delle sue partite più belle fu la semifinale dell’Europeo 1968 contro la Russia a Napoli. Dopo pochi minuti Rivera si azzoppò, l’Italia giocò in pratica in 10 per tutta la gara, non essendoci ancora le sostituzioni. Domenghini fu imperioso nel nascondere ai russi l’inferiorità numerica nei tempi regolamentari e nei supplementari. Fino al 119mo, quando Pierino Prati appoggiò la palla per un lampo che veniva da dietro, Nando Martellini non si rese neanche conto di chi fosse tanto era stato veloce. Era Domingo che si avventò su quella sfera come se fosse l’ultima della sua vita e la ciabattò verso la porta sovietica. Il palo che prese continuò a vibrare durante tutto il sorteggio dopo lo 0 a 0 finale e per i giorni successivi. Si fermò solo quando nella prima finale contro la Jugoslavia, a 10 minuti dalla sconfitta (meritata) la punizione di Domingo centrò l’angolino. Dopo la ripetizione della finalissima, vinta grazie ai gol di Anastasi e Riva, il Presidente della Repubblica Saragat ricevette al Quirinale i neo campioni d’Europa. Non era un grande appassionato di calcio il Presidente, conosceva a malapena Gianni Rivera. Presentazioni di rito, quando fu il suo turno Saragat restò sorpreso : “Domingo? Lei è forse oriundo? E’ forse di origine spagnola?”. “Si, spagnolo di Bergamo”. Quella volta fu visto sorridere anche lui.
Nel 1969 l’idillio con Milano si ruppe. Durante un Inter Verona San Siro lo fischiò. Lui, lui che aveva dato e vinto tutto per quella gente perse il lume. Segnò l’1 a 0 ma non festeggiò né tornò verso la metà campo, restò dietro la porta a questionare con il pubblico. Un uragano di fischi lo seppellì. A gioco ripreso scagliò un pallone in fallo laterale, volontariamente. Chiamò la panchina e chiese il cambio. I compagni gli fecero scudo nel dopo gara, la società lo mandò a chiarirsi le idee per un po’ di giorni dalle sue parti. Mentre le acque si stavano calmando il carico da undici lo mise la moglie del neo presidente Renata Fraizzoli: “Preferisco vedere giocare Corso per dieci minuti che Domenghini per un’ora e mezza”. Quando alla presentazione ufficiale della squadra, Fraizzoli salutò Domenghini, : “Bravo, lei corre molto”, la frittata fu completa: “ Vada al diavolo, lei e sua moglie” fu la risposta che chiuse il suo rapporto con l'Inter.
Arrivò e vinse anche a Cagliari, contro tutto e contro tutti. Quando lo scudetto fu matematico la sua dedica fu una frecciata “Lo scudetto ? Lo dedico all’Inter” mettendo insieme ricordi indelebili e la rivalsa che si stava godendo. Pochi giorni dopo i rossoblu vennero a giocare a Milano, a titolo ormai acquisito. Per quella domenica così speciale i compagni di squadra gli regalarono la fascia di capitano. Capitano del Cagliari, lui, nel suo San Siro…sembrava una bestemmia eppure fu così.
In Messico, ai mondiali del ’70, si giocava in altura. L’aria rarefatta spezzava i polmoni di tutti, non i suoi. Nella semifinale mitica con i tedeschi, il medico azzurro si affannava per convincere Valcareggi a cambiare qualcosa. Domingo, ormai roso dalla fatica, intuì che toccasse a lui “Dottore, se mi toglie, le do un cazzotto”. Discorso chiuso.
Con il tempo, anche a Cagliari due galli nel pollaio si rivelarono troppi ed avere di fronte un interlocutore come come Gigi Riva significava sconfitta in partenza. Un anno alla Roma, poi a Verona, dove si spezzò un tendine. Molti pensarono alle scarpette da appendere. Ma Domenghini la vita l’ha presa a cazzotti da sempre. Si riprese, andò a Foggia ancora convalescente. Rientrò nella gara contro la Juventus. Quando si bevve mezza squadra bianconera lo Zaccheria esplose. Quel diavolo di Domingo era tornato!