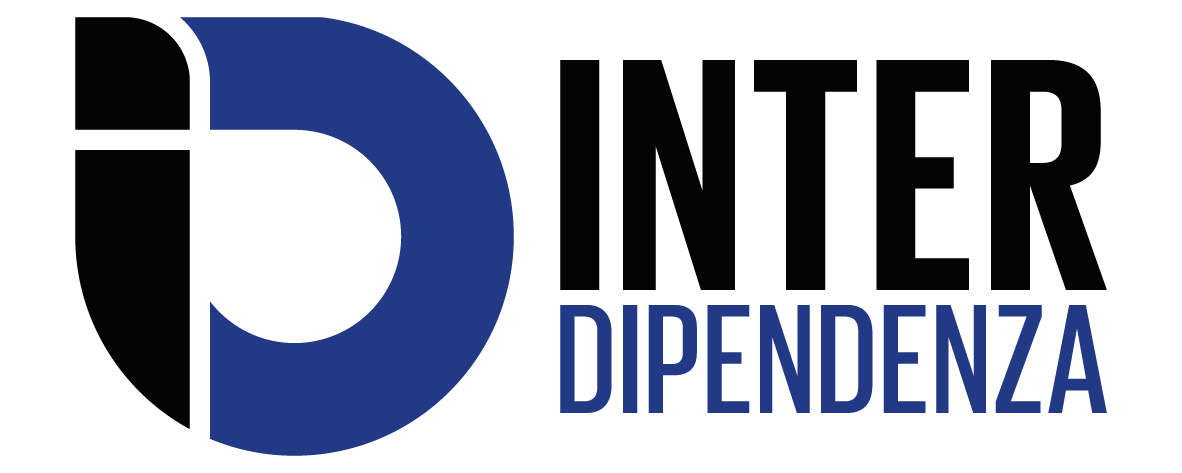Giacinto Facchetti, nella storia dell’Inter con un disco di Mazzola
“Quella mattina, forse la più importante della mia vita, mi misi l’abito nuovo e presi il treno per Milano. Dovevo recarmi in via Larga, vicino al Teatro Lirico, per firmare il cartellino dell’Inter. Mi muovevo come un sonnambulo. I minuti, su quel treno, non passavano mai.
I minuti di attesa in via Larga erano come secoli. Finalmente mi misero una penna in mano e un cartellino davanti agli occhi. Firmai: Giacinto Facchetti. Poi uscii di gran corsa, giù per le scale, con il cuore che mi batteva forte. Ero dell’Inter! Ero uno dell’Inter!”.
Pochi mesi dopo un telegramma. “Al giocatore Facchetti Giacinto. Ci è gradito comunicarti che sei stato incluso a fare parte della comitiva che si recherà nelle prossime feste di Pasqua a Ginevra. Accertarsi di essere in possesso di documento, che gli indumenti siano in perfetta efficienza. Procurarsi per proprio conto il necessario per la cena di venerdì sera. Ognuno è tenuto a mantenere, come sempre, un comportamento serio, educato, rispettoso e disciplinare. Saluti. Meazza.”
Siamo all’inizio degli anni ’60, l’Italia e la sua gente avevano ancora nelle orecchie le bombe della guerra ma cercavano e trovavano la spinta per uscire dal tunnel nella quotidianità delle piccole cose, specialmente nelle periferie. Felice, il papà ferroviere che girava per Treviglio con l’Unità in tasca, gli aveva già trasmesso i virus positivi della gente bergamasca, la tenacia, l’incapacità di straparlare, il rispetto degli altri e di sé stessi, il significato profondo di una parola che oggi spaventa, il senso del sacrificio.
Giacinto partì per Milano con questa valigia di valori, un bagaglio che lo accompagnerà per tutta la vita. Partì per Milano per diventare cosa?
Per diventare uomo e capitano non solo vero ma trasversale, dunque di tutti, dunque unico. Perché la buona fede era ancora un valore condiviso, perché campanilismi, risse volgari e biscardaggini varie non erano ancora entrate nell’immaginario dei tifosi. Perché si tifava potendo ancora riconoscere l’eccellenza degli altri senza doversene vergognare.
Eleganza, correttezza, serietà, talento, in queste parole si racchiude la vita di Facchetti calciatore e uomo, laddove le due cose sono sempre state per lui inscindibili. Gianni Brera lo ribattezzò “Giacinto Magno, l’unico emblema rimasto in un’Italia, calcistica e non solo, a metà degli anni ’70 decadente e malata dentro”.
Tra gli inizi segnati da quella firma e da quel telegramma ed il regno di Giacinto Magno passano quasi 15 anni, tanti quanti bastano per disegnare la storia del personaggio più luminoso del calcio tricolore. E chi avesse da obbiettare porti gli argomenti, o taccia per sempre.
Nella Trevigliese giocava all’attacco. Quando arrivò a Milano all’Inter spadroneggiava Antonio Valentin Angelillo, difficile pensare di sostituirlo con quel giovanotto lungagnone, tanto riservato e silenzioso quanto estroverso di giorno (e soprattutto di notte) era l’angelo dalla faccia sporca . In più Herrera stravedeva per il suo puntero. Ma non si è maghi senza avere intuizioni calate dal cielo. “Come ti chiami? Da domani ti alleni con noi, Cipelletti” gli disse Herrera nel marzo del 1961.
Da quella storpiatura del mister nacque il soprannome che lo accompagnò per tutta la vita. “Questo ragazzo sarà una colonna fondamentale della mia Inter” disse HH con il cinismo tipo dei grandi personaggi, già pregustando di risolvere il rebus di sistemare un solo giocatore e due campioni con una pensata geniale: il terzino fluidificante.
Milano negli anni 60 esplodeva nel suo boom, era una città in pieno fermento alla ricerca del suo posto tra i grandi centri del mondo. Cultura, design, industria formavano volani di entusiasmo e ricchezza un po’ per tutti. Anche il calcio partecipava a questa sete di crescita, il Milan era stato il primo a dominare l’Europa, l’Inter si stava avvicinando a passi rapidi. Per i più sfrontati e fortunati il pallone diventava una scorciatoia formidabile per la fama.
Giacinto aveva due piedi d’oro, un fisico da bronzo di Riace e quella timidezza innata che poteva farlo sentire un pesce fuor d’acqua in quel turbinio di vita. E’ stato suo figlio Gianfelice a raccontare un episodio che lo ritrae alla perfezione. Una balera a Rivolta d’Adda fu il teatro dell’incontro tra Facchetti e Giovanna, la sua futura moglie. Giacinto aveva già notata quella ragazza mentre accompagnava le sue tre sorelle. Era l’unico uomo di casa dopo la morte del papa quando lui aveva 17 anni. Un amico di Giovanna aveva riconosciuto Facchetti e quando gli chiese l’autografo si sentì rispondere “te lo faccio se mi presenti quella ragazza là”.
Gliela presentò, ma le cose non vanno in fretta al sodo come oggi. Seguì una lettera tra i due per fissare il primo incontro, alla fermata dell’autobus che riportava Giovanna a casa dopo il lavoro. Le donne di una volta… lei fece finta di non vederlo e proseguì fino a casa sua a Spino d’Adda, con Giacinto dietro con la sua auto, “ma una volta arrivati non osò entrare in casa mia” – racconta la moglie – “anche perchè chissà quale film si era fatto su mio fratello che era juventino e quindi secondo lui non avrebbe potuto mica tollerare uno spasimante della sorella che per giunta giocava nell’Inter”. Quel cognato, Giovanni, che poco dopo tradì la fede bianconera “cambiò casacca e diventò interista, ma forse non era mai stato veramente juventino – sorride la signora Facchetti –. Era proprio lui, Giovanni ad organizzava le “gite” per andare a seguire Giacinto…”
Non c’erano veline e non c’era gossip in quegli anni, i calciatori, anche quelli famosi sposavano ragazze del popolo o della buona borghesia. Rapporti speciali che diventavano simbiosi totale, “con angoli intimamente privati come quelli dedicati alla fede. Giacinto alla Messa andava sempre da solo, alla chiesa di Treviglio, un rito che lo accompagnava fin dai primi ritiri con l’Inter” ricorda Massimiliano Castellani in un articolo su Avvenire di qualche anno fa. Rapporti destinati a durare in eterno, salvo rare eccezioni. Così come quello tra Giacinto e il Mago Herrera, un lungo percorso di amicizia e rispetto, santificato dal dono ereditario del mister della Grande Inter che lasciò proprio al suo terzino i suoi preziosi taccuini.
L’Inter di Herrera nasce sulle gambe e sulle teste di uomini giovani e forti : Giuliano, Giacinto, Aristide, Tarcisio, Armando, e poi Enea e Spartaco. Nomi antichi, che evocavano un paese che gia' non c’era più, ma nomi che si stavano assemblando per costruire un’armata che avrebbe segnato uno spartiacque nel calcio di tutti i tempi.
La cavalcata nerazzurra degli anni ’60 spazzò il calcio in Europa e nel mondo come un vento impetuoso. Facchetti dominava sulla fascia, le lunghe leve e la facilità di corsa ne avrebbero fatto un atleta da Olimpiade in qualsiasi specialità dell’atletica. Prima i terzini erano due degli ultimi difensori, quando arrivò lui fu una rivoluzione mai vista su un campo da calcio. I 75 gol in 634 partite, di cui 59 in serie A restano un record neanche avvicinato da nessun altro dopo di lui. Quello che ha vinto all’Inter in quegli anni è superfluo ricordarlo, nel 1965 solo Eusebio lo precede nella classifica del Pallone d’oro.
Vale la pena invece ricordare due flash della sua straordinaria carriera. Inter-Fiorentina 13 aprile 1975: un incontro sonnacchioso, ravvivato da un episodio destinato a rimanere nella storia. Facchetti si avvicinò all’arbitro Vannucchi per far notare un fallo di mano di Casarsa. Il fischietto non gradì e sventolò il giallo sotto il naso di Giacinto. L’applauso ironico rivolto all’arbitro non rientrava nel suo bagaglio di uomo e di giocatore, ma quella volta partì per default. Vannucchi trasse le conseguenze del gesto e sancì l’espulsione dicendogli “prego, si accomodi”. L’unico cartellino rosso in una vita sul campo.I 50 mila di San Siro accompagnarono Facchetti con una standing ovation fino al tunnel che porta agli spogliatoi, perché quello era il suo popolo, la gente che aveva affidato sogni e speranze a lui più che a tutti gli altri perché tutti si riconoscevano in lui.
Il secondo fotogramma fissa invece il momento forse più memorabile per Facchetti e per gli interisti. 12 maggio 1965 : all’ingresso di San Siro ad ogni tifoso veniva consegnato un manifestino con una piccola lettera di Helenio Herrera che chiedeva un qualcosa di più per quella sera ai tifosi, anche perchè all’andata verso il termine della partita ii sostenitori nglesi avevano intonato “Santa Lucia”, a mo’ di sfottò. Per molti sarebbe stata una mission impossible ribaltare il 3 a 1 subito a Liverpool. Per l’Inter di Herrera, davanti ad un muro nerazzurro di 80 mila persone, niente era impossibile. Prima Corso, poi Peirò… e poi lui, l'uomo della storia, Nicolò Carosio lo chiamò “il gigante di Treviglio” quando fulminò il portiere inglese. Prima della partita Sandro Mazzola si era assentato per qualche minuto. Un fatto inconcepibile in quel momento così pieno di adrenalina. Quando l’arbitro fischiò la fine e dagli altoparlanti di San Siro partì “ When the saints go marchin in” di Louis Armstrong fu tutto chiaro. Mazzola era andato a portare il disco agli speaker di San Siro per farlo risuonare dopo la vittoria. Quelle note splendide e irridenti accompagnarono i Reds ed i loro tifosi verso l’uscita dalla stadio e dalla Coppa, mentre i nerazzurri andavano in finale per vincerla. Mazzola non ritrovò mai il suo disco.
Gli anni d’oro dell’Inter lo trascinano di diritto in Nazionale, l’esordio è nel marzo del 1963 in Turchia. Ecco, se c’è qualche frizione tra Facchetti ed il mondo e le persone del calcio è legata proprio all’ambiente azzurro. Incredibile a dirsi per quello che per decenni è stato l’alfiere, il capitano, il simbolo orgoglioso dell’azzurro nazionale.
Nel 1966 l’Italia aveva già staccato il pass per il mondiale inglese. L’allenatore azzurro era Fabbri, uno a cui il blocco interista non era mai piaciuto non avendo un Suarez e non si era fatto problemi a metterlo da parte. Uno 0 a 0 nell’amichevole contro la Francia servì da detonatore. Fu proprio Facchetti ad alzare la voce dell’orgoglio nerazzurro, in termini per lui non consueti. “Il vero calcio italiano é quello dell’Inter e non quello della Nazionale italiana…perché il signor Fabbri ci proibisce andare avanti. Lui vuole solo pareggiare, e con i soli pareggi non arriveremmo da nessuna parte in Inghilterra”. Ai mondiali si capì quanto avesse ragione Giacinto. Lui soffrì le pene dell’inferno con il russo Cislenko che gli sgusciava da tutte le parti, poi ci pensò il dentista coreano Pak Doo Ik a giustiziare l’Italia ed il suo tecnico. Giacinto Magno ebbe la sua rivincita, dal dopo Corea in poi la fascia di capitano arrivò sul suo braccio per non staccarsi più.
Con la fascia da capitano degli azzurri fece vibrare lo spogliatoio azzurro e l’Olimpico due anni dopo. La semifinale europea con la Russia si era chiusa sullo 0 a 0. Non c’erano i rigori allora, c’era la monetina. Quando l’urlo del capitano uscì dalla stanza dell’arbitro, tutti capirono e fu festa grande. E poi Messico 68, la semifinale più incredibile di tutti i tempi con i tedeschi che ancora si mordono le mani, e poi sua maestà Pelè a spengere il sogno. Nel brutto mondiale tedesco del 1974 diventa il primo azzurro a giocare due mondiali consecutivi da capitano. Potrebbe giocare anche il terzo se non fosse Giacinto Facchetti, se la sua onestà non lo spingesse anche a sacrifici non comprensibili per altri giocatori. Bearzot lo convocò per i mondiali argentini. Giacinto era reduce da un infortunio e confessò al “Vecio” di non essere nella forma necessaria. Rinunciò e annunciò, a 36 anni, la fine della sua carriera di giocatore.
Qui nasce la seconda vita di Facchetti. Dirigente prima in azzurro, poi un breve passaggio all’Atalanta prima di tornare alla sua Inter con Massimo Moratti che lo volle prima Vice Presidente alla morte di Peppino Prisco, poi Presidente, il 19mo della storia nerazzurra, dal 19 gennaio 2004. Una presidenza maledettamente breve, due anni e mezzo, perché così volle il destino infame. Ma un periodo che nessuno che ami l’Inter potrà dimenticare. Quando scoppia Calciopoli c’è lui a mettere la faccia di fronte al mondo per l’Inter, lui a testimoniare sui fatti che avevano visto l’Inter agnello sacrificale di Moggi e della sua cricca. Si lui, Giacinto Facchetti, che Moggi irrideva sprezzante nella celeberrima telefonata a Cannavaro del 23 agosto 2004 “Fai chiamare Ghelfi, ooh, come si chiama là, il brindellone alto… il presidente!“.
Il figlio Gianfelice ricordava quei mesi in una intervista qualche tempo fa “Si è arrovellato parecchio su quella vicenda, per fortuna la scomparsa avvenuta nel 2006 gli ha risparmiato le porcherie dette sul suo conto. È stato uno dei pochi a essersi scontrato per cambiare un sistema che era marcio, basato sull’illecito, su una forma di potere iniqua, lui questo senso di ingiustizia lo avvertiva molto e sentiva il dovere di reagire, ma in quel mondo era molto solo.” Ci hanno provato in ogni modo ad infangare il suo nome, la sua figura, a tirare in ballo lui e l’Inter per salvarsi le chiappe in nome del teorema “così facevan tutti” . Senza riuscirci, perché l’onestà di Facchetti era quanto di più lontano dalla spregiudicatezza vigliacca di quei personaggi. L’Inter e gli interisti non ringrazieranno mai abbastanza Giacinto per essere stato così, per aver tenuto fuori i colori nerazzurri da quella melma. Quello scudetto del 2006 assegnato a tavolino è la vittoria più bella di Facchetti dirigente e del suo modo di vivere l’Inter. Ma non fu fatta giustizia completa. Quel titolo rappresenta ancora oggi un indennizzo solo parziale per le angherie illegali architettate da chi è stato poi condannato dalla storia e dai tribunali. La parola fine sul comportamento di Facchetti in quella vicenda la mise il tenente colonnello dei carabinieri Attilio Auricchio, che di quella indagine fu il deus ex machina. In una interista al Mattino mise al tappeto gli sciacalli con due frasi: “Facchetti non ha mai posto in atto nulla di illecito. In nessuna telefonata in nostro possesso c’erano contenuti rilevanti per la giustizia ordinaria e per quella sportiva”. Ecco perché quando si parla di Mazzola o Ronaldo l’interista batte i tacchi ma quando si cita Facchetti si commuove.
Calciopoli gli rodeva l’anima, il male incurabile lo aveva assalito da poco. Michele Brambilla, nel suo libro “Vinceremo di sicuro” ricorda così quei giorni. “Erano almeno tre mesi che nel mondo dei giornali girava la notizia di Facchetti malato. Nessuno, è chiaro, lo aveva scritto. Ma di giorno in giorno nelle redazioni si diceva che la fine era sempre vicina. Però il tempo passava senza che arrivasse l’annuncio temuto. Così ad un certo punto si era quasi alimentata la speranza che fosse una delle tante leggende metropolitane che girano nel nostro mondo, “vuoi vedere che…”. Personalmente ho capito che la fine era vicina quando ho sentito Roberto Mancini, su Sky, salutare il Presidente subito dopo la vittoria della Supercoppa: “Gli dedichiamo questo trofeo, ci starà guardando”. Era come se anche l’allenatore dell’Inter avesse capito che ormai non si poteva più nascondere la verità. Un paio di giorni dopo la Gazzetta dello Sport ha scritto quella verità “Facchetti è malato”.
“L’unica volta che l’ho visto piangere, quando i medici gli hanno comunicato della malattia” raccontava la moglie Giovanna. Tre mesi passati a combattere contro un attaccante troppo forte anche per lui, nonostante la sua tempra possente e la sua fede incrollabile. Fino a quel 4 settembre del 2006. Sembrava un giorno uguale a tutti gli altri, ma non fu così. Quel giorno “il cielo si capovolse” per Facchetti, per la sua famiglia, per l’Inter.
Quel giorno tanti parlarono di lui. Al di fuori del mondo nerazzurro il ricordo più bello fu quello dell’ultimo gigante della Gazzetta dello Sport, Candido Cannavò. “Prima ancora che Giacinto chiuda gli occhi per l’ultima volta, emergono da quell’uomo sereno, sulle soglie del mistero, valori che non entrano in nessuna biografia. Lui è stato l’immagine dell’onestà: in senso totale, non solo sportivo. Lui è stato un manifesto di bellezza, vista come dono di Dio: fisica e interiore, prestigio italiano da esportare nel mondo. Lui è stato un monumento di lealtà, la sublimazione dell’agonismo: affrontando qualsiasi avversario non ha mai profittato, oltre la linea della correttezza, di quel «surplus» atletico che la natura gli aveva regalato. Il rispetto per l’uomo è stato, in campo e fuori, un comandamento della sua vita. La moglie Giovanna, forte come una quercia, i figli Barbara, Vera, Gianfelice e Luca devono esserne orgogliosi… Ciao, amato Giacintone, ci sentiamo più poveri
Quel cielo capovolto gli ha impedito di vivere quella che sarebbe stata la giornata più luminosa della sua vita. Il 22 maggio del 2010 anche lui si sarebbe sciolto, avrebbe messo da parte per qualche minuto la sua riservatezza per scatenarsi, per esultare insieme ai suoi ragazzi, insieme al suo amico di una vita, Massimo Moratti. Cambiasso gli dedicò la festa al Bernabeu indossando la sua numero 3 ma quella fu solo la parte “visibile” dell’affetto nerazzurro per il suo antico capitano Quella sera non ci fu un solo interista che nell’ebbrezza della gioia più grande non abbia pensato a lui e a Peppino Prisco lassù, insieme a godersi quel trionfo immersi nelle loro sciarpe nerazzurre. Risentire la dedica finale di Riccardo Cucchi a Facchetti e alla grande Inter in quella sera meravigliosa fa ancora accapponare la pelle.
Giacinto è stato un esempio, non un simbolo. I simboli dividono, creano muri e guerre. Gli esempi uniscono, forgiano modelli positivi da emulare per far crescere una comunità. Lui ha cercato di lasciare un calcio migliore di quello che aveva trovato, prima da giocatore poi da dirigente. Lo ha fatto con il suo lavoro, la sua passione, la capacità di fare squadra, la schiena dritta, sempre e comunque, il rifiuto delle scorciatoie cercate e perseguite da figure che al suo cospetto hanno rivelato inesorabilmente tutta la loro miseria.
E’ questa l’eredità che Facchetti ha lasciato. E non solo agli interisti